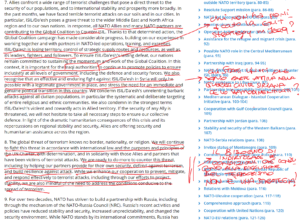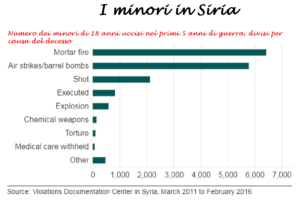Ucraina: la guerra ibrida
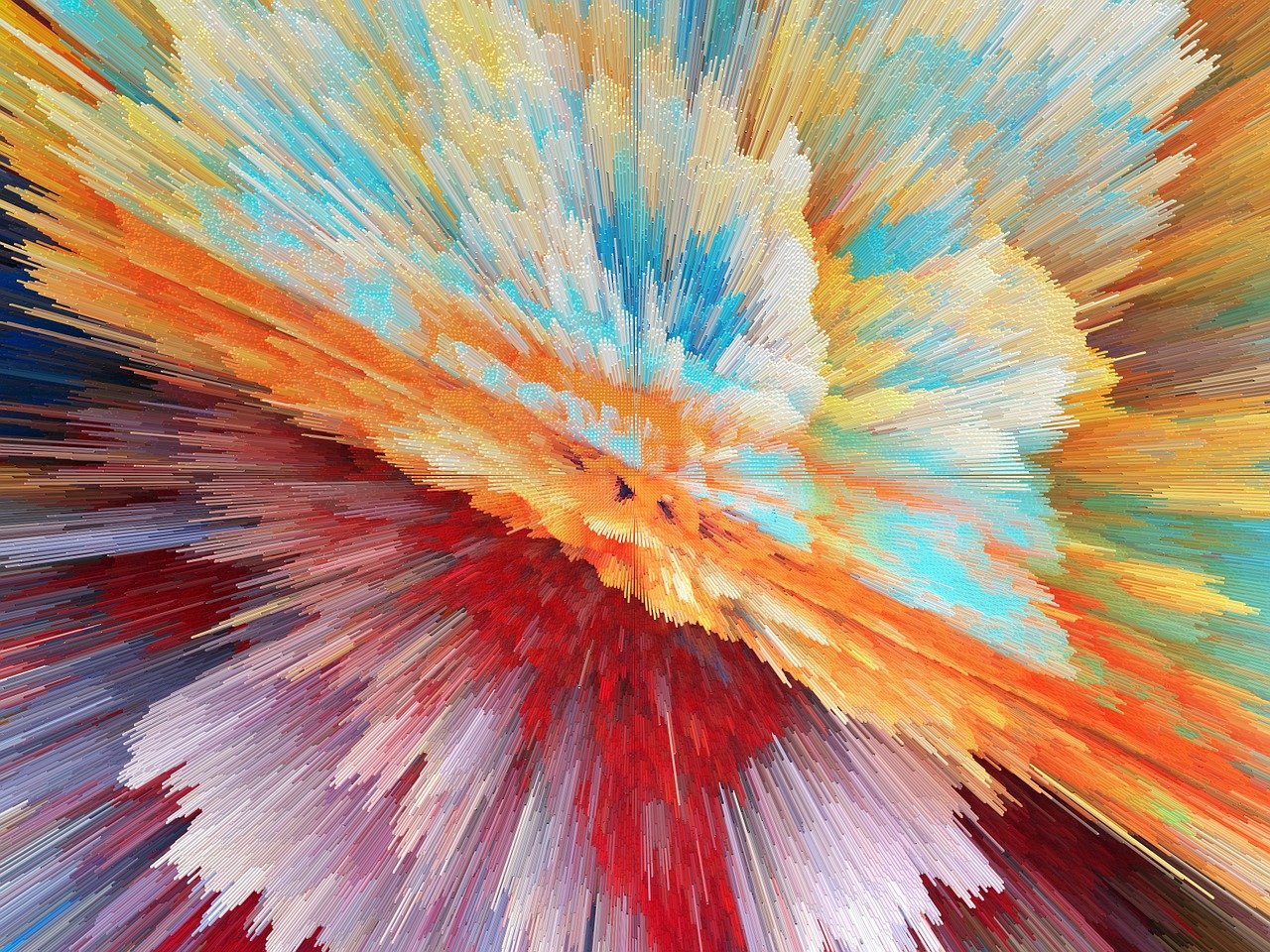
La visione del mondo europea-atlantica, particolarmente riguardo alla legittimità popolare e alla sovranità nazionale, è incompatibile con il “putinismo”. E dato il revanscismo che Putin abbraccia, è chiaro che è una strada senza uscita quella di stabilire una “linea di controllo” all’interno dell’Europa tra l’occidente e quello esso vede come la sfera di interesse della Russia.
È anche possibile che Putin continuerà ad apporre pressioni e a saggiare ulteriormente dove questa linea finirà con l’essere disegnata, e possibili luoghi per farlo non mancano: Bosnia, Moldavia, i più ovvi.
Da dove possiamo partire per tentare di comprendere le tensioni tra Russia e Ucraina?
Deterrenza e diplomazia coercitiva, sono concetti necessari per capire le tensioni tra Russia, Ucraina, Stati Uniti e NATO. Deter è un termine inglese, utilizzato anche in italiano, la cui traduzione più corretta è dissuadere –
La deterrenza è passiva nel suo orientamento. Essa è intesa a prevenire un’azione non ancora intrapresa ed iniziata, sia mostrando che quell’azione è destinata a fallire o che i costi che ne risultano sono significativamente più grandi di ogni beneficio che può essere ottenuto. L’obbligatorietà è più complicata. Essa implica l’ottenere dall’altra parte di fare qualcosa – o iniziare un’azione che altrimenti non sarebbe stata scelta o cambiare il corso di un’azione che è stata già iniziata. Ciò può essere compiuto attraverso minacce, incentivi o una mescolanza di entrambi.
In breve, ogni Paese nel mondo, a prescindere dal suo sistema politico o dai suoi valori, cerca di distogliere altri Paesi dall’intraprendere azioni che esso vede nocive per i suoi interessi nazionali, mentre si adopera ad ottenere influenza che obbligherà altri Paesi ad essere ricettivi delle sue richieste. Allo stesso tempo, per proteggere la sua propria indipendenza e la libertà di azione, cercherà di minimizzare le capacità degli altri di utilizzare la deterrenza e la obbligatorietà contro di esso. Alcuni Paesi possono generare un sufficiente potere di deterrenza e obbligatorietà per le loro proprie risorse, mentre altri potrebbero aver bisogno di mettere assieme una coalizione o cercare un’alleanza protettiva con un alleato più forte.
Deterrenza nella definizione classica di Thomas Schelling, risiede nella capacità che uno Stato deve avere per dissuadere (deter) un altro stato, deve comunicare l’esistenza di queste capacità e deve dimostrare l’impegno ad utilizzare queste capacità nell’eventualità che “linee rosse” precedentemente comunicate siano state oltrepassate.
Obbligatorietà richiede avere sufficienti risorse necessarie per la persuasione – una forza militare capace di imporre costi oppure le risorse economiche per comperare consenso. In entrambi i casi, i leader politici devono calcolare quanto sono desiderosi di spendere e di rischiare in linea con gli obiettivi che ritengono siano i più importanti e vitali per gli interessi del loro Paese, o alle volte, per la sopravvivenza. Applicazioni di successo della deterrenza e della obbligatorietà possono accadere quando, i fini strategici sono bilanciati con i mezzii che saranno utilizzati per raggiungerli. (questa l’ha detta Walter Lippman)
La crisi Russia – Ucraina è parte di un processo più grande di negoziazione, il risultato del quale lo vedremo all’aumentare del potere della deterrenza e della obbligatorietà da una parte e la diminuzione dall’altra.
In superficie questa crisi sembra quasi assurda. Da una parte la Russia che non vuole vedere l’Ucraina ammessa nella NATO. Dall’altra, malgrado la consapevolezza nei mesi passati che l’appartenenza alla NATO per l’Ucraina non è una possibilità realistica nel breve termine, i leader della NATO hanno rifiutato di chiudere formalmente la porta allo stato di membro dell’Ucraina, per evitare di ammettere il principio che ogni Paese europeo abbia il diritto di scegliere i suoi propri accordi di sicurezza.
Esaminando più attentamente la crisi, essa si trova in una complessa configurazione di obiettivi di sicurezza nazionale.
La visione della Russia è che il collasso dell’Unione Sovietica ha condotto ad un collasso analogo del potere di deterrenza e obbligatorietà di Mosca, particolarmente nella sfera militare.
Nel 2008 ed ancora nel 2014, la Russia ha segnalato che non avrebbe più accettato passivamente espansioni, utilizzando impegni militari limitati contro la Georgia e l’Ucraina, per alzare i costi di essere pienamente integrati nella comunità euro-atlantica al di là di un livello accettabile. Oggi la Russia è ancora impegnata nella diplomazia coercitiva per obbligare Kyiv e i suoi alleati occidentali ad accettare un compromesso in cui l’Ucraina resta al di fuori della comunità occidentale.
Per sua parte, l’Ucraina, nelle successive amministrazioni di Poroshenko e Zelensky, ha visto un più stretto allineamento con l’Occidente per controbilanciare gli avanzamenti militari russi. In parallelo, come ulteriore deterrenza contro una potenziale aggressione russa, Kyiv ha cercato di preservare la sua importanza come Paese transito chiave per il gas naturale per raggiungere i mercati europei.
La vendita di energia russa ai clienti europei resta un importante fonte di guadagno per lo Stato russo e nella misura in cui Mosca spera di preservare questo guadagno, potrebbe evitare di danneggiare l’infrastruttura di gas con l’invasione militare. Gli interventi militari in Ucraina nel 2014-2015 nella regione del Donbass hanno avuto luogo lontano dall’infrastruttura per il transito energetico che connette la Russia all’Europa.
Per rafforzare questo deterrente energetico contro la Russia, l’Ucraina vuole che i suoi partner europei chiudano i progetti di transito energetico che aggirano il territorio ucraino e Kyiv ha sollecitato Washington a sostenere questo obiettivo. Per parte loro la Germania, l’Ungheria e la Turchia, tra gli altri, hanno cercato di disconnettere la loro propria sicurezza energetica dalla crisi ucraina.
L’approccio russo combina le minacce militari all’Ucraina con la politica energetica disegnata per disconnettere l’Europa dalle forniture energetiche dal territorio di sicurezza ucraino.
A sua volta l’Ucraina sta cercando la protezione militare dall’occidente, mentre cerca di tenere le forniture energetiche connesse al suo territorio di sicurezza.
Spesso pensiamo che la deterrenza sia ragionevolmente stabile e che duri per decadi, come lo stallo tra Stati Uniti e Unione Sovietica nella Guerra Fredda. Ma nell’odierna crisi in Europa, la deterrenza è tutto fuorché stabile. Essa è cambiata nel corso del tempo e continuerà a farlo; questo a sua volta sta plasmando le scelte strategiche di tutte le parti coinvolte.
Se la Russia non è stata dissuasa dall’attaccare oggi, e se l’Occidente non accetta un accordo imposto sull’Ucraina da Mosca, Kyiv potrebbe essere in una posizione, per la fine della decade di esercitare un più alto grado di obbligatorietà contro la Russia. Questo potrebbe dire, ad esempio, riprendere il territorio perso nel Donbass senza accettare alcun accordo di federalizzazione come immaginato negli accordi Minsk-2, così come procedere con la sua traiettoria verso l’appartenenza alla NATO e all’UE. In altre parole, dissuadere Mosca nel breve termine potrebbe creare le condizioni per l’erosione delle capacità di obbligatorietà russe nel lungo termine.
Gli Stati Uniti sono concentrati di più sulla competizione strategica con la Cina e sul centro di gravità economico e strategico mondiale che sta continuamente muovendosi verso la regione indo-pacifica quindi l’amministrazione Biden o i suoi successori potrebbero nel corso del tempo essere più propensi ad un compromesso sull’Ucraina: accettare una cintura di Stati neutrali tra i mondi euroatlantici ed euroasiatici. Perciò una strategia russa di obbligatorietà, attraverso una via militare coercitiva e la diplomazia economica, potrebbe creare la condizione dove la Russia si sente meno dissuasa dall’Occidente.
Sfortunatamente, mentre si concorda sulla semplicità di questi concetti fondamentali di sicurezza nazionale in teoria, trovare un modo affinché guidino complesse interazioni sul terreno è molto molto più difficile.
Sembra ovvio che una nuova e innovativa iterazione di una dinamica di Guerra Fredda sia inevitabile, quale forma assumerà è molto difficile da immaginare, date le complesse interdipendenze economiche e politiche che legano le due parti.
Questa nuova Guerra Fredda ovviamente era in divenire molto prima della crisi ucraina, e non puramente sull’asse Russia – NATO. La rivalità Stati Uniti – Cina aveva già inspirato la retorica della Guerra Fredda, e sarà presumibilmente la dinamica più significativa che plasmerà il sistema internazionale e la costruzione di sfere di influenza in competizione nelle prossime decadi.
Cosa ci dicono queste prime schermaglie è che questa nuova Guerra Fredda sarà ibrida, con un focus molto sulle armi non cinetiche e tattiche così come sulla forza militare tout court.
Il numero delle crisi protratte che si sono generate nelle passate due decadi, molte delle quali non possono essere risolte in assenza della cooperazione multilaterale, rendono tutte molto imperativo che la nuova Guerra Fredda non si intensifichi nel tipo di contesti proxy e congelino il peacemaking.
Cosa ci suggeriscono gli strumenti e le armi che sono prominenti nell’odierno stallo geopolitico sulla forma del conflitto in divenire?
La minaccia posta dalle armi nucleari non è assente, ovviamente. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina hanno ancora arsenali nucleari in ottimo stato e sistemi in grado di utilizzarle anche più avanzati di quelli della fine della Guerra Fredda. Ma per ora, le armi nucleari non sono state uno strumento di definizione della competizione.
I principali poteri ovvero le armi per gli Stati Uniti e la Cina sono la loro dominazione dei nodi chiave nel sistema globale politico ed economico, che concede loro la determinazione dell’agenda ed il potere che detengono sul controllo, così come la capacità di armare l’interdipendenza globale. Oggi, questo posizionamento è più significativo dei loro arsenali nucleari in termini di permettergli di demarcare le sfere d’influenza e plasmare le dinamiche di potenze globali.
La Russia a questo riguardo ha meno potere da brandire. Tuttavia, la maniera in cui ha fatto leva sul suo veto alle Nazioni Unite, la sua abilità di proiettare una forza di spedizione e la legittimità dell’industria militare sovietica gli permettono di competere su scala globale per l’influenza e le risorse, e di bloccare altri dal farlo.
La Russia non ha un monopolio sulle tattiche militari a cui si affida – dal dispiego dei piccoli “uomini verdi” all’utilizzo della cattiva informazione, gli attacchi cyber, gli alleati proxy nelle zone di interesse occidentali. Pur tuttavia Mosca può dispiegarli in molte arene simultaneamente in modi in cui pochi altri possono.
Solo nello scorso anno, la Russia ha utilizzato queste tattiche per guadagnare influenza e irritare gli interessi occidentali in Sahel, Libia, Siria, Sudan, Balcani e, ovviamente, in Ucraina.
Considerato nel complesso, il tipo di armi e tattiche che gli Stati Uniti, la Cina, la Russia stanno impiegando rappresentano un’aggregazione di potere politico, di capitale economico e militare con cui poche altre nazioni possono competere. Ciò potrebbe rendere più difficile raggiungere la deterrenza e la distensione.
Il segnale che è necessario affinché la deterrenza sia credibile ed efficace è più difficile nel contesto della guerra proxy, cyber e ibrida, dove gli attori, le tempistiche ed anche gli attacchi stessi sono più difficili da leggere.
Ciò rende più difficile contenere le minacce, diminuirle, e la natura ibrida del conflitto – con il suo concentrarsi sulla competizione economica, politica e sociale e sulla forza militare – rende più probabile che i civili e gli altri attori neutrali siano travolti in (e da) esso.
Dal momento che queste nuove leve ibride di potere sono inconfutabili, relativamente comuni e possedute da attori al di là degli Stati in questione, ci potrebbero essere più vie di distruzione. Diversamente dal 1945, viviamo in un mondo dove le imprese private, gruppi violenti erranti, giocatori regionali minori, movimenti popolari di protesta e anche pirati informatici hanno la capacità di frustare le ambizioni delle super Potenze globali.
Un attore di cui non si parla spesso: la Turchia
La Turchia si trova tra l’incudine ed il martello. Non vuole essere l’antagonista della Russia, con la quale condivide interessi strategici vitali, ma ha necessità di mostrare il suo sostegno all’Ucraina e ai suoi alleati NATO. Ciò ha spinto la Turchia a camminare su un diplomatico e calibrato filo sottile di seta.
Erdogan ha visitato Kyiv il 3 febbraio 2022 proclamando il suo sostegno alla sovranità ucraina, reiterando la sua opposizione all’annessione della Crimea e firmando un accordo di libero scambio per segnalare l’impegno turco nella relazione di lungo termine con l’Ucraina. Tutto ciò, ovviamente è stato bilanciato da un’offerta per disinnescare la situazione convocando un incontro trilaterale con Putin, il presidente ucraino Zelensky ad Ankara o Istanbul. Erdogan continua a proporre questa via a Putin.
Le aperture diplomatiche di Erdogan, l’urgenza e l’importanza, sono comprensibili dal momento che Ankara ha affondato la sua mano economica in Ucraina e che tutto quello che sta avvenendo potrebbe regalarle il ruolo di uno dei principali perdenti economici. Nel 2021, la Turchia è diventata il più grande investitore in Ucraina, con investimenti in eccesso di 4 miliari di dollari. Vi sono al momento più di 700 imprese turche che operano sul terreno. Nei passati 5 anni, le esportazioni turche in Ucraina sono quasi raddoppiate a 2.6 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono salite da 2.8 miliardi di dollari e 4,4 miliari di dollari.
La cooperazione bilaterale si sta muovendo particolarmente rapidamente nei settori della difesa e dell’aerospazio. Dal 2019 Kyiv ha acquisito una stima di una dozzina di droni Bayraktar. La marina ucraina ha anche ordinato due corvette MILGEM Ava-class, che saranno prodotte congiuntamente sul territorio turco e sul territorio ucraino. Le due parti hanno già firmato un accordo per costruire infrastrutture di addestramento e manutenzione per i droni turchi in Ucraina, a ciò è seguita la firma di un accordo per la produzione congiunta della prossima generazione di droni che farà leva sulla tecnologia avionica turca e sui motori a reazione ucraini.
La Turchia comprende molto bene che un cambio di regime in Ucraina metterebbe questi investimenti e le relazioni commerciali strategiche a rischio. Tuttavia, lo spazio di manovra della Turchia è in qualche modo limitato e la sua influenza diplomatica nel risolvere questa crisi è modesta.
Potrebbe esserci la possibilità che Erdogan e Putin possano far funzionare le cose malgrado gli ostacoli. Loro, dopo tutto, si sono perfezionati nell’arte della “geopolitica di vendita” – l’abilità di fare dei micro-accordi anche quando sono in disaccordo sul quadro più grande. Questo modo di fare affari è andato relativamente bene in vari teatri dalla Siria, alla Libia, al Caucaso. Questo potenzialmente spiega perché la Turchia permette alle sue compagnie di commerciare con la Crimea e l’Abcasia, malgrado la sua posizione ufficiale in sostegno dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della Georgia. Vi sono poche ragioni per aspettarsi che l’Ucraina cambi il nome del gioco tra Ankara e Mosca.