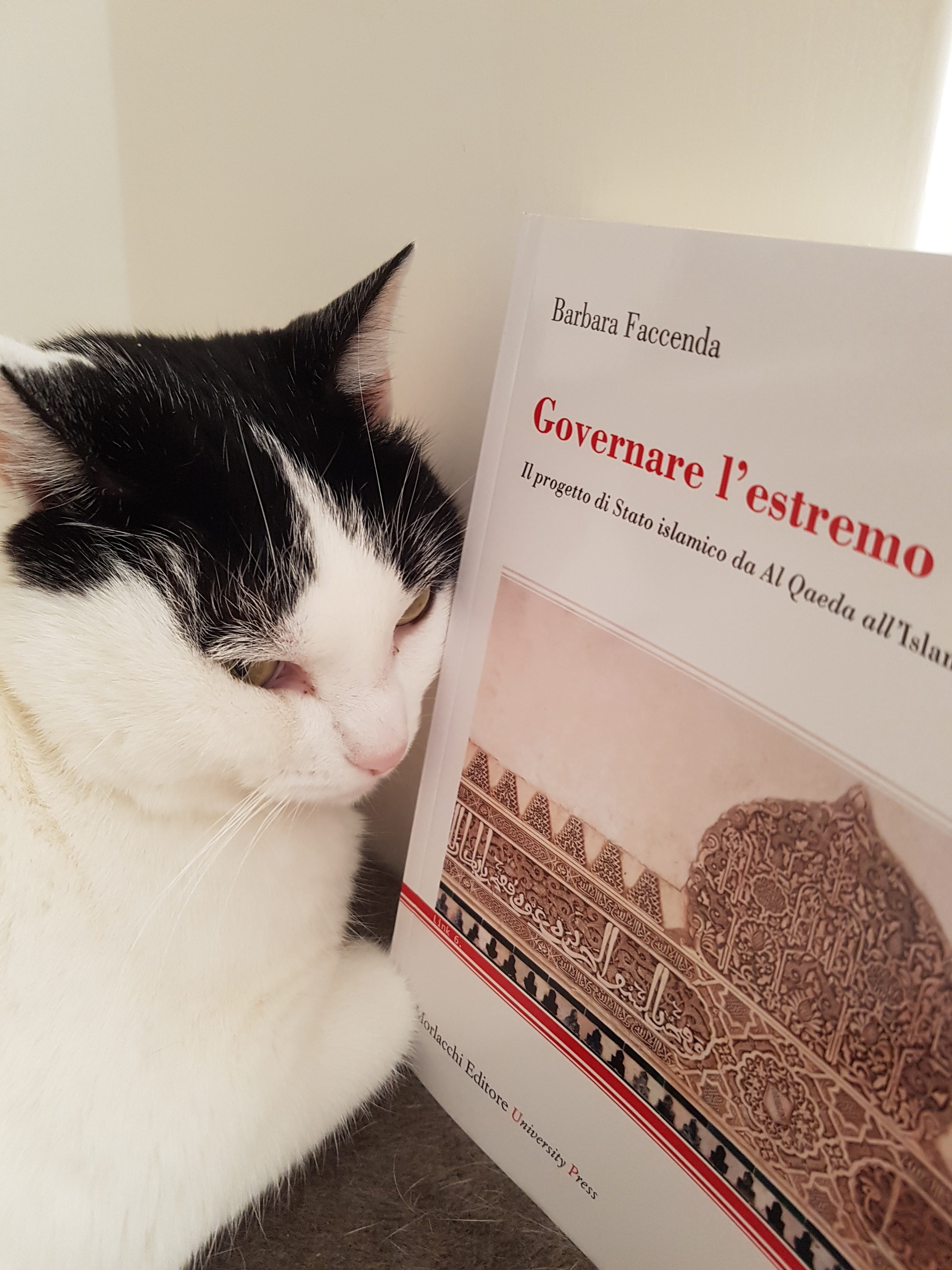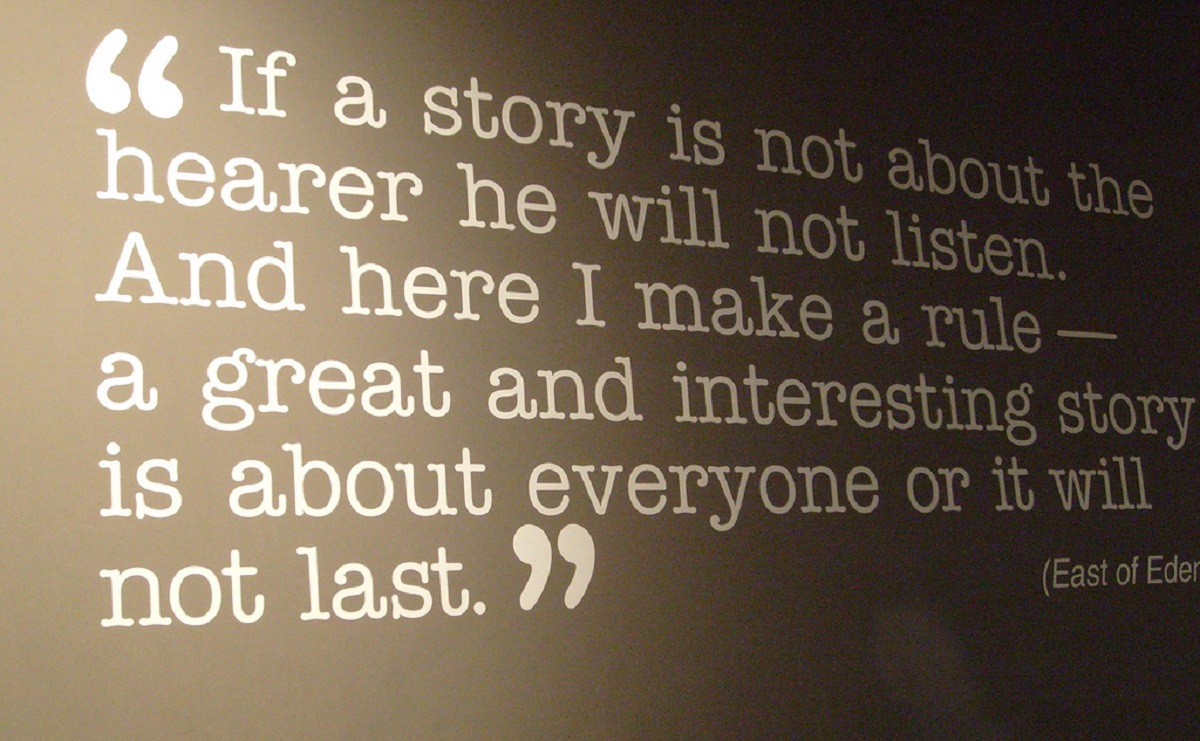La globalizzazione dello Stato islamico

Sempre più chiara è la circostanza per cui la mancanza di lenti coerenti e consistenti attraverso cui comprendere l’impresa transnazionale dello Stato Islamico compromette sia l’interpretazione degli studiosi, che il lavoro dei professionisti riguardo al significato dell’agenda globale del gruppo.
Questo articolo è un tentativo di portare sul tavolo qualche sfumatura, aiutando a comprendere come lo Stato islamico concettualizza – e poi rende operativo – il suo sforzo internazionale.
Il califfato oggi si comprende come un adhocrazia internazionale – una raccolta di gruppi militanti irregolarmente gestita; gruppi diversi, geograficamente dispersi che competono per governare aree – il carattere del quale riflette la compulsione ideologica, i principi strategici e i tratti organizzativi che sostengono le ambizioni di un progetto politico più ampio.
Nel realizzare ciò le iniziative all’estero coincidono con la spinta di forze sia dall’alto verso il basso, che dal basso verso l’altro che danno vita a sincronismo e tensioni sia globalmente che a livello di affiliati.
Mentre l’inclinazione dell’organizzazione dello Stato islamico per un’espansione globale è relativamente nuova nella sua storia lunga decadi, è stato sempre dimostrato il desiderio del gruppo di influenzare le opportunità transnazionali e le reti. Prima del 2006 attraeva foreign fighters e dirigeva attacchi in Giordania, Israele e Turchia.
Per gestire la sua espansione ed assicurare, allo stesso tempo, che i potenziali affiliati fossero ideologicamente allineati e strategicamente utili alla sua causa, ha creato una serie di criteri che i gruppi locali devono soddisfare per essere accetati come provincia (wilayat) formale. Questi creteri, almeno nominalmente, includono giuramenti pubblici di fedeltà al califfo, approvazione della leadership del gruppo locale da parte dello Stato islamico, consolidamento delle fazioni locali sotto un’unica bandiera, comunicazioni corrette tra la leadership locale e il fulcro centrale dello Stato islamico e l’applicazione della metodologia e credo dello Stato islamico. Malgrado la sua retorica assolutista, lo Stato islamico ha, in modo discordante, applicato tali criteri, un fatto che ha alimentato tensioni interne quando alcune province (ad esempio quella ora defunta di Wilayat al-Bahrayn) furono accettate come affiliati. Il dissenso si è diffuso sia al fulcro centrale che a livello di affiliati.
Chiaramente, bilanciare la compulsione ideologica per espandersi con la necessità di assicurare che gli affiliati locali realmente accrescessero le loro capacità piuttosto che detrarle, è stata una sfida per l’organizzazione. Alla luce di ciò, e indipendentemente dall’effettiva estensione di un dato affiliato verso le ambizioni dichiarate dello Stato islamico, al momento presente vi è un solo standard per cui un gruppo è ritenuto un affiliato provinciale, vale a dire se ne ha ufficialmente dichiarato uno.
Ad un estremo dello spettro, vi sono le province principalmente simboliche e ampiamente inattive come quelle in Algeria e in Arabia Saudita, all’altro vi sono le province come quelle della Siria, Iraq e West Africa che hanno raggiunto il consolidamento di uno Stato territoriale. Nel mezzo vi sono quelle che sono emerse come beneficiarie di uno sforzo globale di ristrutturazione messo in pratica nel 2018: Wilayat Sharq Asiyya (Est Asia) e Wilayat al-Sumal (Somalia), entrambe mostrano evidenze minimali di un intervento diretto del nucleo centrale dello Stato Islamico, sebbene restino operativamente attive e sono regolarmente rappresentate nei prodotti media ufficiali.
Per comprendere come la sua diffusione globale accade, è utile valutare gli affiliati dello Stato islamico caso per caso sulla base di queste considerazioni:
a. l’estensione del controllo centralizzato e dell’influenza esercitata dalla leadership centrale su tale affiliato;
b. i tipi specifici di attività che sono condotte da tale affiliato in nome del nucleo centrale;
c. la frequenza con cui tale affiliato e le sue attività sono utilizzate come leva dal nucleo centrale per scopi strategici e di propaganda.
Variazioni ovvero spudorata inconsistenza tra questi piani –situazioni che in altri contesti avrebbero causato potenzialmente sfide all’esistenza stessa del gruppo – sono ammesse proprio dalla natura adhocratica dello Stato islamico. È la stessa natura che gli permette di transitare da movimento estremista violento clandestino a proto-stato burocratico e indietro verso l’estremismo violento e così via, negli anni recenti senza interruzioni .
Le adhocrazie sono organizzazioni strutturalmente fluide in cui gruppi di progetto che interagiscono tra di loro lavorano verso uno scopo condiviso o un’identità. La fluidità che caratterizza un adhocrazia risulta nel suo essere flessibile a condizioni strategiche – alle volte può essere più gerarchica e burocratica mentre altre più informale e come una rete – con un gruppo
di specialisti nel fulcro centrale che guida la direzione complessiva e la collaborazione dell’organizzazione, attraverso una serie di meccanismi decisionali decentralizzati. È proprio il modello di queste caratteristiche essenziali dell’adhocrazia la chiave della sopravvivenza dello Stato islamico negli anni recenti. Questi tratti gli hanno permesso di proiettare un’immagine di un movimento molto più coerente e monolitico di quanto fosse in realtà. Questo carattere blando adhocratico ha significato che lo Stato islamico è stato in grado di essere altamente adattabile e innovativo in come ha risposto al cambiamento costante delle condizioni strategiche, negli anni recenti.
Dal momento che le organizzazioni adhocratiche resilienti sono anche inclini alla debolezza, generalmente esse si affidano alle tecnologie communicative e allo sviluppo di personale specializzato per sincronizzare gli sforzi e le agende. Per questa ragione, interruzioni nella comunicazione possono avere serie ripercussioni nella coerenza strategico-operativa così come nella compattezza del gruppo.
Inoltre, le adhocrazie contengono un alto rischio nella scelta del momento opportuno per la transizione organizzativa verso strutture più formali o informali, e ciò può agire da catalizzatore di un logoramento della rete. Questa dinamica è presumibilmente evidenziata nella fretta dello Stato islamico nel dichiarare un califfato e creare un “sistema di controllo” burocratico di pieno spettro in Siria e Iraq nel 2014, per vederlo poi decimato pochi anni dopo.
C’è stato un punto in cui lo Stato islamico ha indietreggiato dall’idea di avere un proto-stato nell’arco delle frontiere dell’Iraq e della Siria (almeno per il momento presente). Non vuole dire che esso sia entrato in un mondo “post-califfato”, piuttosto ci suggerisce semplicemente che ha riconosciuto internamente che esso non aveva né la capacità né la necessità di cucire il suo marchio nel Medio Oriente nello stesso modo in cui lo aveva fatto fino al 2018.
È stato un cambiamento che ha avuto l’effetto di inquadrare le branche dello Stato islamico dell’Iraq e della Siria come tali – rami. Essenzialmente, esse erano dequalificate: il loro status complessivo nel progetto di califfato globale alterato in un modo tale per cui esse erano “solo” parte della rete globale.
Visto attraverso gli occhi del fulcro centrale dello Stato islamico, l’espansionismo deve essere sempre compreso, almeno in parte, come un esperimento in una guerra guidata dalla narrativa. Dichiarando wilayat nel mondo, stava fissando una rivendicazione a nuovi territori mostrando di esserci non solo dopo le sue perdite in Siria ed Iraq, ma di essere in continua espansione.
La globalizzazione dello Stato islamico: i meccanismi
La globalizzazione dello Stato islamico aiuta il gruppo a costruire una profondità strategica e a gestire il rischio attraverso i suoi affiliati. Spingendo simultaneamente su molteplici fronti con un “inasprimento” asimmetrico e attacchi complessi più convenzionali, ha testato le capacità della coalizione globale e dei suoi affiliati locali in West Africa ed Est Asia. Allo stesso tempo, il fulcro centrale dello Stato islamico è pronto a capitalizzare il calo della pressione militare in Iraq e Siria.
Le attività in corso e sincrone degli affiliati aumentano la probabilità che ad un dato momento le risorse del controterrorismo occidentale terminino. Le operazioni degli affiliati e le comunicazioni connesse dal fulcro centrale attorno a questi successi operativi sono perciò un moltiplicatore di forze.

Una prima tipologia di attività espansionista si è palesata nelle Filippine. Il gruppo Maute – Hapilon (una sub-fazione del gruppo Abu Sayyaf), che ha giurato alleanza allo Stato islamico nel 2014, ha ricevuto direttive strategiche e tattiche prima e durante l’assedio di Marawi e Mindanao nel 2017, incluso le “migliori pratiche” per la difesa urbana così come un esteso supporto remoto per la produzione di media e l’editing. Tuttavia, sebbene i jihadisti dai vicini Stati asiatici erano contati nei rangi Maute-Hapilon, nessuno effettivamente ha viaggiato dall’Iraq o la Siria.
In contrasto, in Nigeria, gli interventi dello Stato islamico erano inizialmente limitati, ma destinati a diventare più sofisticati agli inizi del 2015.

I quadri dello Stato islamico hanno iniziato a fornire assistenza al gruppo esternamente noto come Boko Haram (Jamaat Ahlussunnah lid-Dawa wal Jihad), che giurò fedeltà a Baghdadi e divenne Wilayat Gharb Ifriqiyya nella primavera di quell’anno, attraverso un Consiglio – in remoto – utilizzando tecnologie di comunicazioni internet criptate. Questo Consiglio era fondamentalmente relativo a questioni di giurisprudenza religiosa, che i militanti di Boko Haram entusiasticamente richiedevano a causa della carenza di iman addestrati nell’affiliato. Poi lo Stato islamico ha progredito il sostegno attraverso l’invio di un piccolo gruppo di consulenti per accrescere le competenze materiali dei nuovi sostenitori. Questo addestramento era centralizzato in un luogo sicuro nella foresta Sambisa nel Borno, sebbene alcuni disertori hanno fatto notare che i consulenti li accompagnavano anche nei combattimenti per valutare le loro tattiche, che erano descritte così improduttive da essere “come suicidi”. Questi stessi disertori rivelarono che furono allora ri-addestrati in piccole unità di manovra, con competenze anti-aeree e di manovra di veicoli corazzati. I consulenti li aiutarono a migliorare le qualità di operatori di media locali e nelle pratiche di sicurezza operativa dei leader chiave, facilitando anche i trasferimenti finanziari bimestrali attraverso i corrieri.
Un altro meccanismo di espansione è l’integrazione di jihadisti di esperienza nei ranghi locali, più raro degli altri. Tra il 2012 ed il 2014 lo Stato islamico ha proattivamente inviato foreign fighters dall’Asia centrale e del sud che aveva addestrato e indottrinato in Iraq e Siria verso i loro Paesi di origine per unirsi con frammenti di gruppi jihadisti locali, formando dei nuclei di quadri iniziali di Wilayat. Probabilmente la più chiara dimostrazione di questo è Abu Nabil al-Anbari come “leader delegato” delle province libiche nel 2014. Prima di questa nomina, Anbari era un comandante militare in Iraq. L’episodio in Libia nondimeno parla della sperimentazione della flessibilità e innovazione dello Stato islamico nel suo espansionismo globale.
Tensioni interne
Le dinamiche a trazione e pressione tra l’organizzazione centrale e i suoi affiliati producono frizioni, alcune delle quali possono provarsi fatali per la relazione. Lo Stato islamico perde un franchise a causa di differenze strategiche e metodologiche. Durante il suo primo tentativo di franchising nel 2012, l’allora leader Abu Bakr al-Baghdadi invia il suo vice Abu Ali al- Anbari in Siria per monitorare la sua startup siriana, Jabhat al-Nusra. Il pungente resoconto al suo capo mette in moto la spaccatura tra lo Stato islamico e Jabhat al-Nusra e il più consequenziale scisma tra lo Stato islamico e Al Qaeda. Da queste esperienze, la leadership dello Stato islamico ha identificato la necessità di una relazione più direttiva tra il punto centrale e la periferia della sua organizzazione.
Le frizioni tra il nucleo centrale e gli affiliati si sviluppano in tre aeree sensibili: la selezione e la guida dei leader, la correzione degli errori metodologici e la direzione strategica.
La gestione della leadership è importante per ogni organizzazione e la storia propria dello Stato islamico di gestione e transizione dei leader a tutti i livelli è stata una forza generale per il gruppo. Vi sono delle eccezioni rilevanti. Il reclutamento da parte dello Stato islamico di Boko Haram per diventare la provincia del West Africa e la seguente degradazione del suo leader carismatico, Abubakar Shekau, è alla radice della frattura del gruppo in due distinte fazioni, entrambe hanno giurato alleanza allo Stato Islamico. In Yemen, Afghanistan, Mindanao, lo Stato islamico ha fallito nel dispensare la sua dottrina di gestione della leadership. Ciò ha avuto l’effetto di minare la legittimità e la stabilità di quei franchise che lottavano per un rapido cambio dei leader a causa della scarsa selezione e delle inadeguate procedure di sicurezza.
Mentre la provincia Khurasan in generale appare imitare il punto centrale nei suoi attacchi contro la minoranza sciita hazara e con campagne di assassini urbane – più recentemente con obiettivo le donne che lavorano per i mezzi di comunicazione – altri sono stati riluttanti nell’adottare le regole dello Stato islamico.
La provincia West Africa oltre a rifiutare la gestione della leadership da lontano, ha ignorato gli editti religiosi sull’abolizione dei bambini soldato e degli attentatori suicidi donne come combattenti regolari. Il gruppo ha anche fallito nello stabilire un esercito opposto all’utilizzo di milizie in maniera casuale, contrari ai consigli degli addestratori dello Stato islamico.
Da un punto di vista propagandistico, attraverso l’espansionismo globale, il movimento è in grado di mostrare esso stesso in continua offensiva, una percezione che è fondamentale se serve per stare al passo con le forze centrifughe del suo marchio e mantenere una coesione organizzativa.
Per questa ragione in particolare – il fatto che lo Stato islamico raccoglie gli enormi dividendi simbolici vantandosi delle sue province – che dobbiamo comprendere, con occhio critico, il suo globalismo.
L’Africa sub-Sahariana è stata per lungo tempo nel mirino di gruppi che avevano come obiettivo il jihad globale.
Con altre aree del mondo che ricevevano la porzione più grande dell’attenzione da parte delle forze di controterrorismo occidentali, sia Al Qaeda che lo Stato islamico hanno tratto vantaggio dall’opportunità di accrescere la loro presenza nella Regione.
L’Africa sub-Sahariana come Regione per lo Stato islamico è fondamentale perchè è proprio qui dove esso può raggiungere una vera e propria “capacità di successo” ovvero la capacità di generare e mantenere un alto tempo operativo per gli attacchi. Le province dello Stato islamico nell’Africa occidentale e nell’Africa centrale rispettivamente, hanno il potenziale di conquistare e mantenere territorio nel Sahel e lungo la costa sud est Swahili, in una maniera simile a quella che il fulcro centrale dello Stato islamico fu in grado di raggiungere in Iraq e Siria durante il suo picco.
L’attenzione dello Stato islamico spostata verso l’Africa sub-Sahariana dovrebbere essere vista come parte di una strategia deliberata in una Regione dove è molto più facile lavorare lungo e oltre le frontiere rispetto ad altre parti del mondo.
Con fondi per conflitti che consistono approssimativamente in 100 milioni di dollari, l’organizzazione manterrà la sua abilità di seminare nuove imprese e rafforzare le esistenti. Attraverso questo processo, quelli che una volta forse erano puramente gruppi locali, ora possono conquistare una dimensione transnazionale a differenti livelli. Anche se, fondamentalmente, sono guidati da preoccupazioni parrocchiali e rimostranze, gli affiliati dello Stato islamico possono evolvere e diventare più globali in natura. Diversi gruppi jihadisti africani hanno cambiato notevolmente il modo in cui combattono dopo essere diventati affiliati dello Stato islamico, in alcuni casi implicando sia miglioramenti tattici che evoluzione strategica. Questi gruppi sono ora capaci di lanciare operazioni molto più complesse e sono rappresentati di più nella propaganda dello Stato islamico.
Un esempio di questo è la Provincia dell’Africa centrale dello Stato islamico nota anche con l’acronimo inglese ISCAP – Islamic State Central Africa Province – la quale si è considerevolmente trasformata da quando è stata formalmente riconosciuta dallo Stato islamico nell’aprile del 2019.
All’inizio del 2020, gli estremisti violenti in Mozambico hanno iniziato ad operare in unità più grandi e a organizzare attacchi più sofisticati contro obiettivi di più alto profilo, come le capitali dei distretti. Alcune prove recenti ci suggeriscono che ISCAP sta adesso focalizzandosi più sul conquistare il cuore e la mente della popolazione nel nord del Mozambico. Una serie di attacchi nel marzo del 2020 hanno visto gli estremisti deliberatamente evitare vittime civili e distribuire il bottino di guerra – cibo rubato, medicine, carburante – ai residenti locali.
Un segno della crescente forza di ISCAP in Mozambico: i suoi militanti hanno preso il controllo della città portuale di Mocimboa de Praia – un obiettivo strategico – nell’agosto del 2020. Due mesi più tardi, i militanti ISCAP hanno lanciato degli attacchi transfrontalieri dal nord del Mozambico nel sud della Tanzania. Il devastante attacco nella città di Palma a marzo, che ha ucciso una dozzina di persone, ha alcuni degli elementi caratteristici dei classici attacchi dello Stato islamico, inclusa la decapitazione di stranieri e gli obiettivi di interessi economici occidentali. Ha forzato la sospensione di un progetto del gigante petrolifero francese Total del valore di 20 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto e le attività di esplorazione collegate ad esso.
Gli eventi degli ultimi due anni ci suggeriscono che gli affiliati africani dello Stato islamico non sono più un evento marginale al suo punto centrale operativo in Siria ed Iraq. Il fulcro centrale dell’organizzazione sia dipendente adesso più che mai sulle attività militari dei suoi affiliati nel continente.
E’ necessario prestare più attenzione, più da vicino, per vedere dove lo Stato islamico sta finanziando nuovi affiliati e dove le branche esistenti o le province stanno manifestando le loro capacità e abilità
migliorate in uno sforzo volto a tenere il califfato vivo.