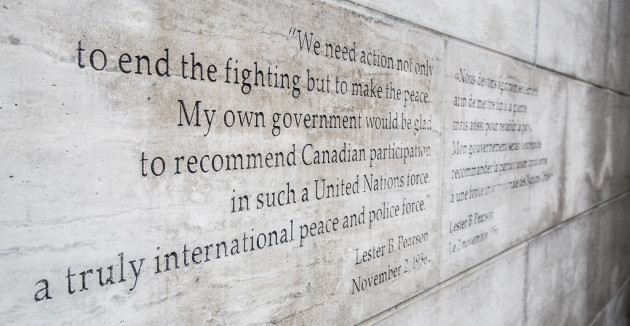Il peacekeeping è sull’orlo del baratro?

Il 70° anniversario delle missioni di peacekeeping non ha, comprensibilmente, destato particolare entusiasmo (e neanche tanto risalto).
Nel lontano 1948 il Consiglio di Sicurezza inviò osservatori militari in Medio Oriente come supervisori della fine della prima guerra arabo-israeliana, dando il via a più di 70 missioni delle Nazioni Unite (NU), diventate un vero e proprio tratto distintivo dell’Organizzazione.
Le operazioni NU sembra che stiano entrando in una nuova, difficile, fase. Nelle due passate decadi, le forze di peacekeeping hanno svolto un lavoro solido, sebbene raramente citato, allo scopo di stabilizzare Paesi di piccole e medie dimensioni come la Sierra Leone o Timor Est. Agli inizi di quest’anno, hanno portato a conclusione un’altra, ampia, missione di successo in Liberia. Con la chiusura di queste operazioni, le NU adesso si trovano a concentrare in maniera maggiore i propri sforzi di peacekeeping su 5 grandi e problematiche operazioni in Africa. In ogni caso, gli elmetti blu restano sparsi in contesti dove si trovano di fronte ad una violenza endemica.
Gli esperti delle NU sono avvezzi alle regolari crisi che scuotono l’organizzazione, pur non sovvertendola. Dal Mali alla Siria, le NU rivelano serie difficoltà non solo a porre fine ai conflitti, ma a mantenere la pace. Tuttavia, malgrado gli attacchi all’Organizzazione, che indicano una frustrazione diplomatica, il Consiglio di Sicurezza persiste nel portare avanti questi processi. Non ci sembra di poter escludere in maniera definitiva che le NU siano, al momento, sull’orlo di una batosta nel Medio Oriente e ciò potrebbe creare una rottura decisiva a New York.
Dieci anni fa, storie di violenza endemica nella Regione del Darfur del Sudan spesso erano, in Occidente, i titoli di stampa, le notizie con cui si aprivano i telegiornali. Sebbene questo conflitto continui in maniera sporadica, oggi esso è del tutto dimenticato. A luglio, il Consiglio di Sicurezza ha deciso di tagliare il numero delle forze di peacekeeping nella missione UNAMID (missione africana delle Nazioni Unite in Darfur), di circa la metà, con l’idea di chiudere completamente la missione nel 2020. La decisione ha creato un mormorio intorno al Consiglio. Nondimeno, la riduzione di UNAMID potenzialmente segna un punto di svolta per le operazioni di peacekeeping.
Dalla Siria al Burma (Myanmar) le forze armate stanno perseguendo campagne militari inarrestabili e, nella loro ricerca di vittoria, puniscono indiscriminatamente i civili. In entrambi i casi la “pace” che ne risulterebbe sarebbe caotica.
Queste crisi minacciano di turbare alcune delle norme basilari che sono maturate attorno alla risoluzione delle guerre civili nel periodo post-Guerra Fredda. Per restare rilevanti, le operazioni di peacekeeping, si dovranno senz’altro adattare ai nuovi scenari di post-conflitto. Se i “peacemakers” vogliono avere una qualsiasi possibilità di porre fine alle guerre odierne, essi devono imparare a ragionare come degli assassini a sangue freddo.
Le tre passate decadi sono state un periodo di raro successo per il peacemaking internazionale. Nel periodo della Guerra Fredda, gli sforzi diplomatici e di mediazione significavano che la maggior parte dei conflitti si concludeva in accordi negoziati piuttosto che in vittorie decisive di una parte o dell’altra.
Sebbene molti di questi accordi siano stati fragili e non sostenibili, essi hanno contribuito ad un declino complessivo delle guerre e delle morti che hanno causato.
Le principali potenze nel sistema internazionale del post-Guerra Fredda, guidate dagli Stati Uniti, hanno deciso di adottare “un trattamento standard” all’insorgere della violenza, caratterizzato dalla convinzione che un accordo mediato e negoziato, l’uso delle forze di peacekeeping e l’aiuto estero fosse la strada giusta per risolvere i conflitti futuri.
Anche i governi e i gruppi di ribelli che erano desiderosi di utilizzare la violenza di massa per raggiungere i loro obiettivi si sentivano obbligati a lavorare con mediatori esterni e permettere alle agenzie umanitarie di assistere i civili che soffrivano.
Anche gli Stati Uniti, pur essendo intervenuti in Iraq e in Afghanistan, alla fine hanno riconosciuto che non possono utilizzare solamente la forza per pacificare entrambi e hanno investito di più nella ricerca di accordi politici.
L’odierna decade ha visto un’importante inversione quando gli sforzi politici per porre fine alle ondate di conflitti nel mondo arabo hanno iniziato a vacillare.
Dall’altra parte, uomini forti come Assad e i suoi sostenitori internazionali hanno generato un aumento degli sforzi militari, utilizzando le campagne internazionali contro l’IS per giustificare il loro approccio senza regole ignorando sistematicamente le condanne esterne alle loro azioni. I sostenitori di Assad adesso, presumibilmente, pur considerando le accuse di oltraggio alle regole internazionali come inevitabili, sono persuasi che non avranno né alcun effetto e né alcun costo sulle loro operazioni.
Per fare un esempio tra i tanti: lo scorso anno l’offensiva in Myanmar lanciata contro i Rohingya conteneva in maniera inequivocabile la convinzione che ci sarebbe stato un criticismo esterno, ma che esso non avrebbe avuto alcun effetto sulla tempistica delle operazioni.
Resta chiaro che i leader politici e militari nelle zone di guerra si curano sempre meno delle condanne per il loro comportamento, considerandole come un piccolo prezzo da pagare per ottenere delle decisive vittorie.
Oggi, le guerre civili durano più a lungo ed è sempre più probabile che si concludano con la vittoria di una parte piuttosto che con un accordo negoziato.
Pur tuttavia gli accordi negoziati non si sono ancora estinti definitivamente. Recenti storie di successo come il processo di pace colombiano mostrano che c’è ancora uno spazio politico per i peacemakers per creare accordi complessi.
In molti casi i mediatori dovrebbero accettare un ruolo meno ambizioso ma ugualmente urgente, vale a dire quello di ridurre i rischi in cui incorrono le comunità e i ribelli nel processo di disarmo o di dislocamento.