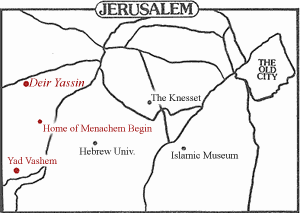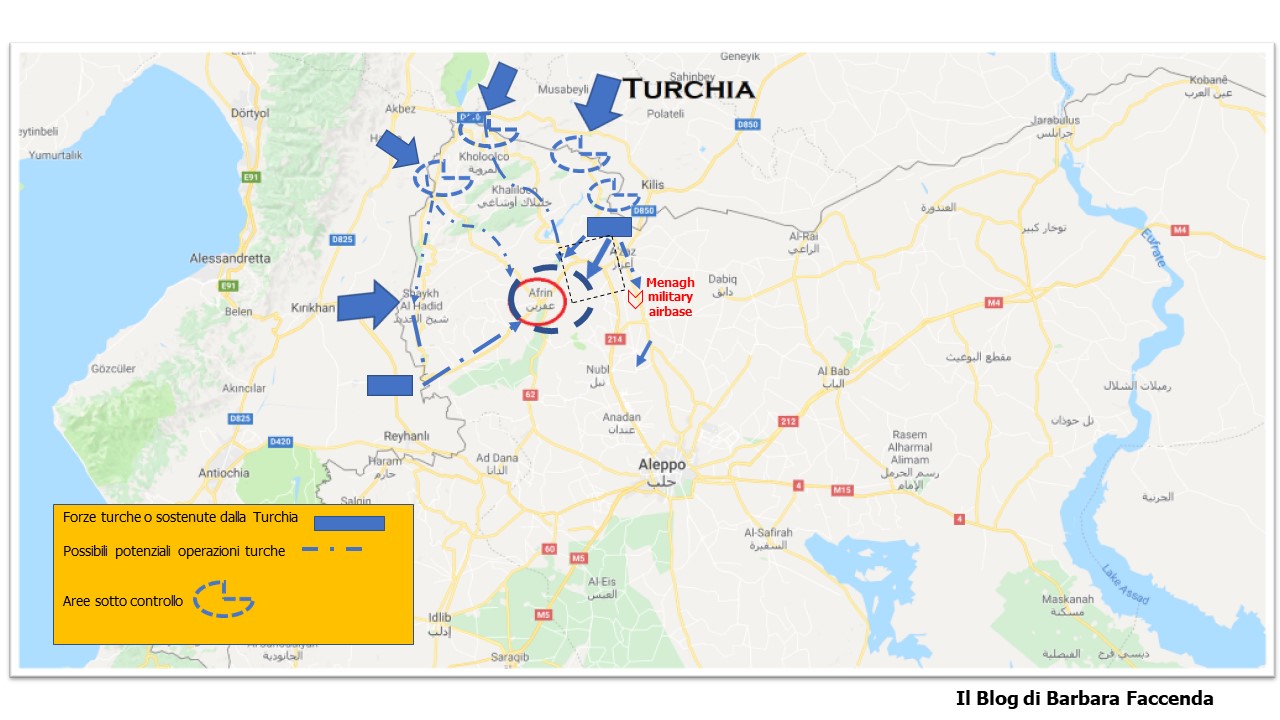L’ASSE DELLA RESISTENZA: CHI SONO?

Nel conflitto Hamas-Israele alcuni degli attori coinvolti si trovano bel al di fuori di Gaza. Come ho sempre detto i conflitti contemporanei sono complessi, con dinamiche multiple di livelli diversi che si muovono contemporaneamente e per quanto si voglia cercare di offrire strumenti per la comprensione ad un pubblico di non addetti ai lavori c’è sempre il rischio di banalizzare nel tentativo di semplificare.
In questo caso cerco di semplificare una serie di attori che si citano spesso, ma che temo non si conoscano. Quando sentite dire o leggete “asse della resistenza” (alle volte qualcuno dice “asse del male” citando a casaccio visto che si riferisce a tutt’altro spazio geopolitico), sappiamo davvero da quali attori è composto e chi sono? Anche in questo caso vi sorprenderete leggendo di quanto sia ancora molto più complesso di quanto si possa immaginare.
Asse della resistenza – Membri chiave
Iran
Siria
Hezbollah
A cui si aggiungono:
a) Ansarullah (Houthis) Yemen
Il movimento Houthi si è sviluppato dal gruppo rivivalista sciita Zaydi negli anni 1990, in reazione alla crescita del salafismo attorno a Saada, cosi come alla diffusa percezione che il governo centrale trascurasse la regione. In linea generale, gli Houthi promuovono una ideologia neo-zaydista che è poco definita. Probabilmente l’unica chiara espressione di questa ideologia è la credenza che i discendenti del profeta, i Sada, hanno il diritto e l’autorità per governare. Questa convinzione è riflessa nella sistematica nomina di membri del gruppo sociale nelle posizioni di alto rango nel governo e nell’apparato militare. Mentre gli Houthi alle volte esprimono un desiderio di stabilire uno Stato moderno e repubblicano, come pubblicato nel 2018 nella “visione nazionale per lo stato moderno dello Yemen“, la loro recente imposizione di tasse, la segregazione di genere e la loro preferenza per gli Hashemiti nelle posizioni di leadership, suggerisce il loro obiettivo di ripristinare una dominanza storica socio politica saada–zaydista nello Yemen.
Ad oggi vi sono due principali elementi nella strategia e nel pensiero Houthi.
- Gli integralisti, che sono riluttanti nel contenere il dissenso e sono più inclini all’uso della violenza per raggiungere le loro ambizioni politiche. Sono in ascesa per via del loro successo militare. Il loro obiettivo è di governare tutto lo Yemen e di continuare a dare battaglia, dove è possibile, all’Arabia Saudita.
- I moderati che sono di gran lunga più deboli; si concentrano sul controllo del territorio dall’ex Repubblica araba dello Yemen nel nord del Paese. Sono più aperti ad un impegno con l’Arabia Saudita e a lavorare con gli accordi proposti dalle Nazioni Unite.
Gli Houthi hanno ereditato molta della loro esperienza, tecnologia e armi dall’apparato di sicurezza dello Yemen quando hanno preso il controllo del governo nel 2014, lo sviluppo di capacità tattiche è giunto attraverso l’assistenza tecnica dell’Iran.
La relazione Iran-Houthi è basata in interessi e obiettivi condivisi piuttosto che in una ideologia comune.
Gli Houthi continueranno a partecipare nella campagna dell’Iran per indebolire l’Arabia Saudita fino a quando ciò aiuterà il gruppo a consolidare il suo governo nello Yemen.
Piuttosto che proxies, come sono spesso descritti, gli Houthi sono partner eguali in un condiviso progetto militare che beneficia entrambe le parti.
Gli Houthi restano soprattutto un attore yemenita con obiettivi locali.
Sarebbe un errore assumere che l’Iran possa dirigere il comportamento Houthi.
La visione del mondo è cospiratoria: essi vedono l’Unione Europea ed i suoi Stati membri come servili agli Stati Uniti e la cospirazione israeliana realizzata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti. Pur tuttavia, gli Houthi vogliono il riconoscimento internazionale. In questo senso, sono desiderosi di impegnarsi diplomaticamente con l’UE che considerano meno concentrata nella campagna contro di loro rispetto agli Stati Uniti, la Gran Bretagna o l’Arabia Saudita.
b) Asaib Ahl al-Haq (AAH) – Iraq
L’Islamic Revolutionary Guard Corp (IRGC) crea AAH nel 2006, reclutando al-Khazali (leader del gruppo), che allo stesso tempo comandava un brigata militare: Jaysh al-Mahdi. Una milizia formata nel 2003 da un religioso sciita influente iracheno: Muqtada al-Sadr, per combattere l’occupazione degli Stati Uniti. Inizialmente al-Khazali era un membro leale di Jaysh al-Mahdi anche nota come Mahdi Army, studia negli anni 1990 giurisprudenza islamica sotto la tutela del padre di Sadr, Grand Ayatollah Mohammad al-Sadr a Najaf .
L’Iran sfrutta questa spaccatura offrendo vasti finanziamenti e addestramento ad al-Khazali per formare AAH con l’obiettivo di aggiungere questo gruppo alla sua lista di proxies in Iraq.
c) Harakat Hezbollah Al-Najuba (HHN) – Iraq
Creata nel 2013 subito dopo la guerra civile siriana capeggiata dal Akkram al-Kaabi fino ad oggi. Al momento è composta da tre brigate: Liwa Ammar Ibne Yasir, Liwa Al-Hasan Al-Mujtaba e Liwa Al-Hamd. Al-Kaabi era membro di Mahdi Army di Muqtada Sadr Mujtaba che aveva combattuto contro le forze americane in Iraq tra il 2003 ed il 2008. Tuttavia, lo sgretolamento dell’accordo di cessate il fuoco tra Mahdi Army e le forze militari americane ha avuto come conseguenza che molti dei suoi membri di alto rango defezionano. Al-Kaabi, una di queste figure di spicco, rompe con Sadr e si unisce a AAH. In AAH gli é affidato il compito di creare una organizzazione franchise in Siria unitamente alle milizie sostenute dall’Iran.
La lotta interna per la leadership all’interno di queste milizie in Siria unitamente alla situazione disperata dovuta al collasso del governo in Iraq spinge AAH a concentrarsi sulla sicurezza in Iraq all’interno dell’ombrello delle Popular Mobilization Forces (PMF). Ciò conduce all’allontanamento di Al-Kaabi da AAH, che porta quindi alla formazione di HHN.
La divisione tra AAH e HHN concede all’Iran una opportunità strategica. Mentre AAH ha un ramo politico così come prende parte attivamente al processo elettorale, HHN è puramente militaristica in natura. Similmente AAH ha amalgamato la sua ideologia con il fervore iracheno. Dall’altra parte HHN opera in un meccanismo transtatale, sia in Iraq e Siria e le loro mutue regioni di frontiera. Questo modus operandi li avvicina a Hezbollah in Libano, che funziona anche in differenti regioni. Dall’altra parte, lo stretto coinvolgimento di Hezbollah nella politica nazionale non è qualcosa che HHN condivide. In Siria, HHN è diventata il gruppo più longevo e uno dei leader proxy delle milizie dell’Iran, operando attorno a Damasco, Deir ez-Zor, Aleppo e Hama. HHN è anche parte delle PMF in Iraq con la sua dodicesima Brigata. Le province di Anbar, Nineveh e Saladin sono sotto il suo controllo: cruciali perché si legano attorno alla frontiera Siria-Iran. Inoltre sono zone a dominanza sunnita. Questi due aspetti accordano ad HHN un ruolo delicato e significativo nel calcolo complessivo della strategia proxy iraniana.
d) Kataib al-Imam Ali (al-Imam Ali Battalions), o KIA Iraq
Creato nel giugno del 2014 come ramo militare del partito Harakat al Iraq al Islamiyah (Movimento islamico in Iraq). Il gruppo si è mobilitato per la prima volta quando il Grand Ayatollah Ali al-Sistani emana una fatwa chiamando volontari ad unirsi ai servizi di sicurezza, pur inviando volontari nelle PMF formando la 40° Brigata delle PMF.
Nei combattimenti contro lo Stato Islamico (IS), KIA dispiega forze in Iraq all’inizio del 2014 e in Siria nel 2015, l’ultima campagna presentata come una misura difensiva per proteggere il sito sacro Sayyeda Zainan, il sito sacro più importante in Siria. KIA combatte in battaglie a Tikrit, ovest di Mosul, al-Qaim. Nel processo sviluppa un personaggio di spicco delle PMF Ayoub Falih Hasan al-Rubayie (noto con il soprannome Abu Azrael) che ottiene un profilo sociale mediatico molto vasto per le sue bizzarie sui campi di battaglia.
Nel 2020-2012 KIA diventa più silente, concentrandosi sulla costruzione di reti commerciali e sull’attività politica. Shibl Al-Zaydi, il leader ancora oggi, agisce come un coordinatore del gruppo di resistenza in competizione e come un convogliatore di messaggi per i libanesi Hezbollah e i funzionari di sicurezza iraniani.
e) Kataib Hezbollah (KH) (Battalions of the Party of God) – Iraq
Creata dalla fusione di “gruppi speciali” creati e condotti dalle IRGC-QF nel 2005-2007.
La più forte fazione individuale delle PMF irachene con il controllo di dipartimenti chiave (capo di stato maggiore, sicurezza, intelligence, missilistica)
Subordinata e parzialmente finanziata dalle IRGC-QF, conduce specifiche azioni seguendo le loro istruzioni, direzione e controllo. L’Iran fornisce a KH assistenza finanziaria, militare e condivide prodotti di intelligence, così come seleziona, sostiene e supervisiona la sua leadership. KH è nominalmente governata dallo Shura Council composto da un segretario generale, cinque deputati e almeno 33 membri, più “supervisori” provenienti dalle IRGC-QF e Hezbollah libanese.
Finanziato parzialmente dallo Stato iracheno, KH aziona la 45°, 46° e 47° Brigata delle PMF, finanziate dallo Stato (iracheno). La catena di comando, nominalmente, si dipana dalla commissione Popular Mobilization – dominata dalle KH, fino all’ufficio del Primo Ministro, e poi quindi al Primo Ministro. In pratica, le brigate KH delle PMF frequentemente disobbediscono alla catena di comando governativa mentre restano giuridicamente organi dello Stato iracheno.
f) Kataib Sayyid al-Shuhada (KSS) (Masters of the Martyrs Brigade, aka Kataib Abu Fadl al-Abbas, Kataib Karbala) – Iraq
Costruita attorno alla responsabilità e alla base di potere di Mustafa Abdul Hamid Hussein Utabi, aka Abu Mustafa al-Sheibani o Hamid Thajil Warij al-Utabi, uno dei membri fondatori di Kataib Hezbollah KH.
KSS diventa parte delle forze di sicurezza irachene quando forma la 14° brigata delle PMF.
Nell’ottobre del 2014 KSS minaccia l’Arabia Saudita, asserendo che ogni cosa umana o materiale di origine saudita sarebbe stata un obiettivo futuro, legittimo, avvertendo che il gruppo avrebbe colpito e distrutto il regno. Nel luglio del 2018 il gruppo dichiara di inviare propri militanti a combattere le forze governative in Yemen.
Nel novembre del 2021 KSS rivendica di aver arruolato 49,000 volontari in una nuova campagna di reclutamento per prepararsi ad una grande battaglia contro le forze americane in Iraq.
IRGC – QF e Hezbollah libanese forniscono a KSS l’assistenza finanziaria, militare, condivisione di prodotti di intelligence così come sostegno ed aiuto nella selezione e supervisione della leadership.
A seguito dell’uccisione mirata da parte degli Stati Uniti, nel gennaio 2020, del comandante delle IRGC-QF Qasem Soleimani, Teheran ha concesso ai visitatori KSS un trattamento di alto profilo, circostanza che ci suggerisce che hanno ottenuto uno status più alto rispetto a tutto gli altri gruppi ad eccezione di Kataib Hezbollah e Harakat Hezbollah al-Nujaba.
KSS è parzialmente finanziato dallo Stato iracheno, ed aziona la 14° Brigata delle PMF. Stesso schema di disobbedienza attuato dal KH.
g) Fatemiyoun – Afghanistan
Composto da rifugiati sciiti afgani in Iran e da membri della minoranza sciita Hazara all’interno dell’Afghanistan. Gli Hazari compongono dal 9 al 10 percento della popolazione totale afgana di 38 milioni. Considerati infedeli dai talebani sunniti e obiettivo di attacchi mortali dagli anni 1990, centinaia di migliaia di Hazari sono fuggiti in Iran, dove il governo li ha reclutati nei ranghi della milizia, in cambio di pagamenti alle famiglie, cittadinanza e altre protezioni legali.
h) Zainabiyoun – Pakistan
Costruita dalle IRCG nel 2013, quando l’Iran interviene in Siria a sostegno del presidente Bashar al-Assad. La brigata prende il nome dal sito sacro Sayyidag Zainab, un sito importante di pellegrinaggio sciita a sud di Damasco oggetto di attacchi da parte dei militanti sunniti.
Le modalità di reclutamento per i combattenti pakistan sono piuttosto complesse ed incentrate sulla città iraniana di Mashhad. Alcune delle reclute si sono spostate dall’Iran al Pakistan, mentre altre erano già in Iran verosimilmente come studenti. Un terzo gruppo apparentemente si è mosso in Iran dopo essere stato espulso dagli Emirati Arabi Uniti.
Un certo numero di queste reclute provengono dalla regione Parachinar dell’allora Kurram Tribal Agency nel nord ovest del Pakistan che confina con la provincia afgana Paktia. Il distretto a maggioranza sciita è collocato nella regione sunnita tribale ultra conservatrice, che è stata la scena di conflitto settario. Queste dinamiche hanno condotto alla formazione di identità settarie locali molto più salienti rispetto ad altre aree del Pakistan.
Agli inizi del 2020, l’Iran ufficialmente segnala i suoi legami con Zainabiyoun, la cui bandiera é issata alle spalle del comandante della forza aerea IRGC Amir Ali Hajizadeh insieme alle bandiere degli altri gruppi sostenuti dall’Iran nella regione.