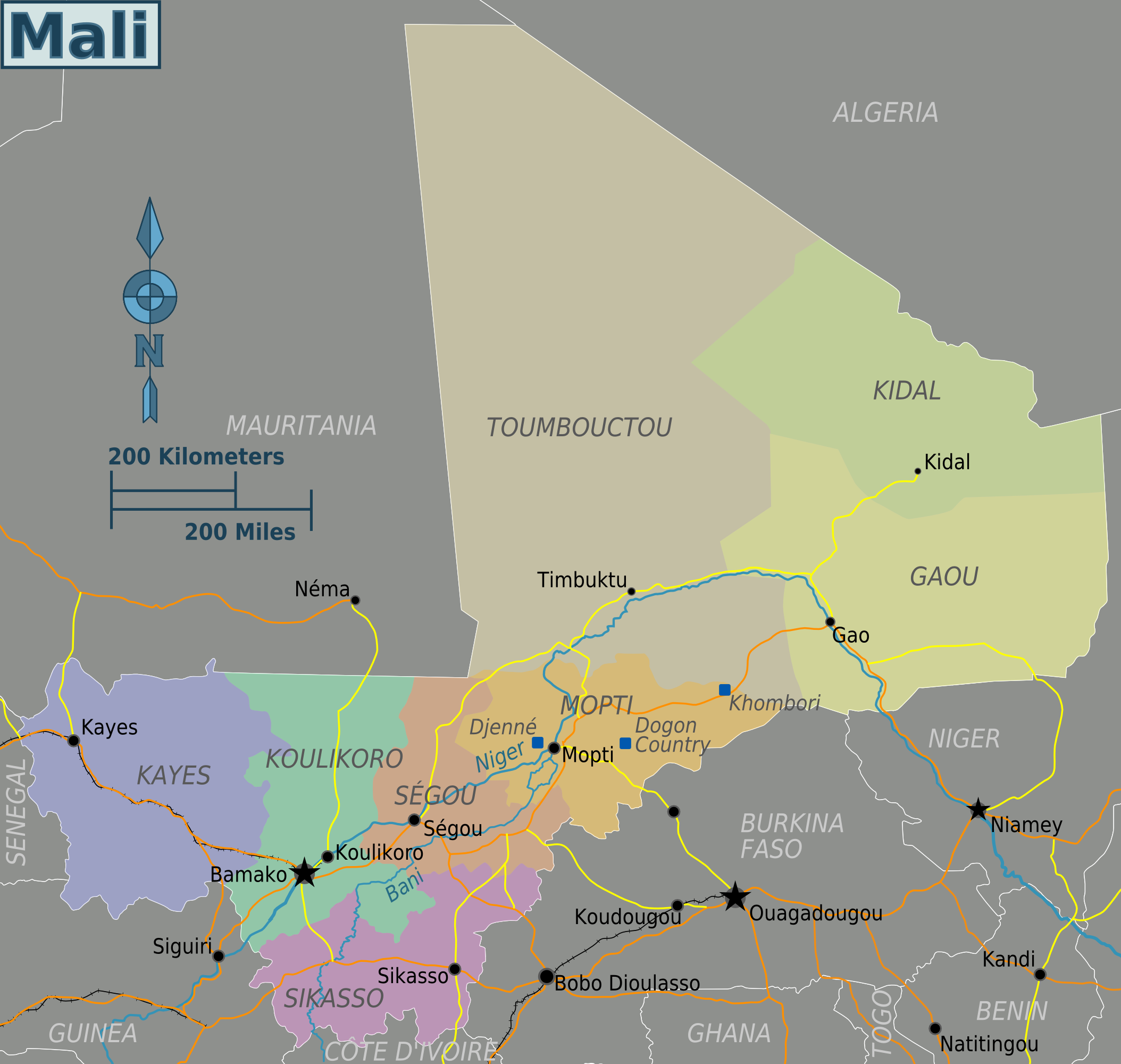Al-Shabaab chi sono e cosa vogliono?
Al-Shabaab ha come obiettivo quello di rovesciare il governo di Mogadiscio, utilizzando regolarmente attentatori suicidi contro il governo, i militari ed i civili.
Al Shabaab significa “la giovinezza” in arabo; è la più grande organizzazione militante che cerca di controllare il territorio somalo per stabilire una società basata sulla rigida interpretazione della Shariah. Tuttavia, il gruppo conduce attacchi anche in Paesi vicini come il Kenya.
Origini
Shabaab è emerso come organizzazione indipendente intorno al dicembre del 2006 dopo il dissolvimento dell’Unione delle Corti islamiche (UCI), per la quale rappresentava il braccio militare.
Prima di ciò le origini del gruppo restano ambigue. Il suo primo leader: Aden Hashi Ayro, in un primo momento si era unito ad un movimento islamista chiamato Al Ittihad Al Islamiya (AIAI) nel 1991, un movimento all’interno del sistema giudiziario somalo, che voleva prendere il controllo della Somalia. Ayro potrebbe aver guidato un gruppo blando di militanti AIAI e ciò significherebbe che Al-Shabaab potrebbe essere esistito in una qualche forma prima di costituire la branca militare dell’Unione delle Corti. Tuttavia, Al-Shabaab principalmente si è sviluppato come parte dell’UCI ed Ayro ha contribuito al reclutamento e all’addestramento dei militanti. Le prime attività del gruppo includevano multipli assassini di lavoratori internazionali nel Somaliland tra il 2003 ed il 2005 così come il disseppellimento del cimitero italiano nel 2005. Inoltre, Al Shabaab ha sostenuto l’utilizzo della violenta rappresaglia contro i lavoratori del Governo Federale Transitorio della Somalia dopo che diversi membri dell’ICU furono assassinati nel 2005, presumibilmente dal GFT.
A metà del 2006, l’UCI ottenne il controllo della Somalia centrale e del Sud. Ayro voleva connettere la battaglia somala con l’agenda del jihad globale, ma altri leader dell’UCI invece volevano piuttosto focalizzarsi su obiettivi nazionalisti e creare uno Stato islamico in Somalia. Alla fine del 2006, le Nazioni Unite con le truppe etiopi spingono l’UCI fuori da Mogadiscio, circostanza che fa collassare l’Unione che presto si scioglie. Ayro e Al Shabaab rimangono però attivi.
L’invasione etiope della Somalia rappresenta un evento cruciale per Al-Shabaab, alimentando risentimento contro una forza straniera occupante e permettendo ad Al-Shabaab di diventare la maggiore forza di resistenza in Somalia.
Sebbene Al-Shabaab si focalizzasse sull’attacco alle forze etiopi e dell’Unione Africana, il gruppo cercava anche di connettere la sua causa con il movimento globale jihadista, specialmente attraendo combattenti stranieri e promuovendo una relazione con Al Qaeda. I leader di Al Shabaab e di Al Qaeda raggiunsero relazioni reciproche positive, Al Shabaab offrì rifugio a membri di Al Qaeda nella regione.
Nel 2008 la relazione tra i due gruppi si stringe. Nel Maggio dello stesso anno, Ayro viene ucciso in un bombardamento americano e Ahmed Abdi Godane, chiamato anche Mukhtar Abu Zubeyr, diventa il leader del gruppo. Pubblica una dichiarazione in cui elogia Al Qaeda ed esplicitamente si sposta verso l’enfatizzazione della battaglia in Somalia come parte del jihad globale.
Al Shabaab inizia ad allinearsi ad Al Qaeda sia nell’ideologia che nella tattica e ad avere come obiettivi i civili con attacchi suicida molto più frequenti. La leadership dell’organizzazione inizia ad includere molti dei membri Al Qaeda. Al-Shabaab fa leva sulla sua relazione con Al Qaeda per attrarre combattenti stranieri (c.d. foreign fighters) e donazioni in denaro dai sostenitori di Al Qaeda. Inoltre, membri di Al-Shabaab viaggiano all’estero per addestrarsi con Al Qaeda.
2009: Al-Shabaab giura alleanza ad Al Qaeda
All’inizio del 2009, dopo una serie di attacchi contro obiettivi americani e delle Nazioni Unite in Somalia e contro le truppe etiopi, Al-Shabaab diffonde un video in cui formalmente giura alleanza ad Al Qaeda.
2012: Al Qaeda annuncia formalmente una fusione tra le due organizzazioni.
Pur tuttavia Al Shabaab e ad Al Qaeda continuano ad identificarsi come organizzazioni separate.
Nell’aprile del 2015, i militanti di Al Shabaab attaccano l’università Garissa in Kenya uccidendo almeno 147 persone. Il gruppo rivendica l’attacco come mezzo per spingere le truppe keniote a ritirarsi dalla Somalia.
Nel 2015, lo “Stato islamico” (IS) diffonde un video in cui invita Al Shabaab, come il più prominente gruppo jihadista dell’Est Africa, a giurare alleanza a loro, l’IS. Qualcuno ha sussurrato che Al Shabaab potrebbe accettare la richiesta, ma per ora Al Shabaab resta “fedele” ad Al Qaeda.
Al-Shabaab: la leadership
Hassan Dahir Aweys. Ci si riferisce a lui come al leader spirituale del gruppo, ma la sua precisa relazione con il gruppo non è chiara. Aweys ha guidato il braccio militante dell’AIAI. Arrestato dal governo somalo nel giugno del 2013, l’anno successivo fu trasferito dalla prigione agli arresti domiciliari.
Mahad Mohammed Karate. Capo di Amniyat, il ramo intelligence del gruppo, che fu responsabile dell’attacco all’università Garissa. Qualche volta Karate è stato descritto come il vice comandante di Al Shabaab. È stato ucciso dalle forze di difesa keniote nel febbraio del 2016, ma il gruppo nega la sua morte.
Ahmad Umar. Chiamato anche Abu Ubaidah, nominato nuovo leader nel settembre del 2014, subito dopo che Godane fu ucciso in un bombardamento americano. Non ci sono molte informazioni disponibili su di lui.
Al-Shabaab: ideologia e obiettivi
Ideologia: islamista, jihadista, salafista.
L’obiettivo principale è quello di far cadere il governo somalo e di stabilire un emirato islamico nel paese basato su una stretta interpretazione della Sharia.
In aggiunta ad i suoi obiettivi in Somalia,
Al Shabaab ha adottato in maniera sempre maggiore un orientamento che prevede l’inquadramento della battaglia somala come parte del movimento jihadista globale.
Il primo leader del gruppo, Ayro, aveva ricevuto l’addestramento in Afghanistan e ha modellato il principi del gruppo intorno agli obiettivi dei Talebani. Nei territori che controlla, Al Shabaab, ad esempio ha messo in pratica un sistema di punizione tale per cui i ladri sono puniti con l’amputazione delle mani e le donne accusate di adulterio con la lapidazione. Il gruppo ha anche vietato attività come la musica, i video, radersi. Nello sforzo di liberare il paese dall’influenza straniera, Al-Shabaab ha chiuso la BBC accusandola di promuovere un’agenda colonialista anti- musulmana.
Al-Shabaab: risorse
Ha ricevuto finanziamenti e addestramento da jihadisti stranieri di Al Qaeda. Ha ottenuto fondi anche da comunità della diaspora somala, incluso quella che si trova negli Stati Uniti. Nel 2010, ad esempio, 14 americani sono stati accusati di sostenere materialmente e di raccogliere fondi per Al-Shabaab.
I governi americano e somalo hanno accusato l’Eritrea di sostenere Al Shabaab attraverso armi e finanziamenti. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che altri paesi e gruppi forniscono al gruppo missili, armi e addestramento in violazione dell’embargo sulle armi imposto alla Somalia del 1992. I gruppi e i paesi accusati includono: Djibouti, l’Iran, la Siria, la Libia, l’Eigitto, l’Arabia Saudita ed Hezbollah.
Al-Shabaab: un pericolo molto maggiore rispetto allo “Stato islamico” in Somalia
Lo “Stato islamico”(IS) ha ricevuto una buona notizia dalla Somalia l’anno scorso, quando ad ottobre, una piccola fazione militante, allineata allo “Stato islamico” ha preso il controllo di Qandala, una città portuale nel nord del paese, per più di un mese, per poi ritirarsi. È stata la prima volta che un gruppo legato all’IS ha occupato una città in Somalia.
Al-Shabaab resta un gruppo molto più pericoloso dell’IS.
Lo “Stato islamico” desidera una presenza in Somalia e ha fatto la corte ad Al-Shabaab per due anni. Tuttavia Al-Shabaab controlla strisce di territorio in Somalia, in una regione piena di paesi pro – occidentali.
Come abbiamo visto Al-Shabaab ed Al Qaeda condividono una lunga storia. Molti fondatori del gruppo somalo si sono addestrati nei campi afghani di Al Qaeda, da quando il primo leader del gruppo ha incontrato Osama bin Laden nel 1998. Un gran numero di prominenti membri di Al Qaeda in Africa dell’Est si sono associati ad Al-Shabaab, incluso Fazul Abdullah Mohammed, uno degli individui coinvolti nell’attentato all’ambasciata di Nairobi; era anche dietro all’attentato del 2002 al hotel e alla compagnia aerea nella costa del Kenya.
Se Al-Shabaab avesse dovuto unirsi all’IS, l’avrebbe fatto da un bel pezzo quando i benefici erano più chiari.
Il marchio dell’IS recentemente è stato macchiato dalle sue perdite in Siria, Iraq e Libia ed ha meno capacità, adesso, di fornire ad Al-Shabaab un supporto operativo significativo.
Al-Shabaab probabilmente ha notato quanto poco beneficio il gruppo estremista nigeriano Boko Haram ha ottenuto dall’essersi unito ufficialmente all’IS nel 2015. La scorsa estate l’IS ha accelerato un potenziale scisma all’interno di Boko Haram nominando un emiro rivale di Abubakar Shekau, che ha guidato Boko Haram dal 2010.
Al-Shabaab ha reso chiaro a chi è fedele, resistendo alle aperture dell’IS e cacciando letteralmente i suoi stessi membri sospettati di simpatizzare con l’IS.
Voci dell’apertura allo “Stato islamico” da parte del leader di Al-Shabaab (che non si sa se sia vivo o meno)
Tuttavia l’odierna fedeltà del gruppo estremista somalo con Al Qaeda non preclude per sempre uno spostamento verso l’IS. Ci sono voci che Mahad Karate, il potente leader dell’unità Amnyat nutra delle simpatie per lo “Stato islamico”. Sebbene non si sappia per certo se sia vivo o meno, se sostenesse l’unione con l’IS, e se ciò avvenisse, richiederebbe molto probabilmente un’operazione di purga della maggior parte dell’odierna leadership del gruppo somalo.
Va detto che dopo che Abdiqadir Mumin, il leader della fazione che per poco ha preso il controllo di Qandala, ha dichiarato la sua alleanza all’IS (ottobre 2015), i militanti di Al-Shabaab hanno attaccato alcuni dei suoi uomini, costringendoli a nascondersi per venire fuori solo per prendere la città portuale.
Le lusinghe dello “Stato islamico” al popolo somalo
Da parte sua l’IS adesso pare che cerchi di aggirare il gruppo rivolgendosi direttamente al popolo somalo. Ha infatti diffuso un video, lo scorso anno, in cui rivolgendosi ai somali promette una governance migliore rispetto al draconiano regno di Al-Shabaab.
Molto difficile da vendere!
Nel caotico ambiente della Somalia, i gruppi militanti e i movimenti estremisti tradizionalmente hanno costruito le lealtà o essendo al forza dominante, oppure fornendo servizi alla popolazione, in taluni casi: facendo entrambi.
Vincere il consenso o la fedeltà dei somali è, al momento, al di fuori della capacità dello “Stato islamico”.
Tutto ciò fa sì che Al-Shabaab resti la minaccia più rilevante in Somalia e resterà così per il prossimo futuro.
Il suo principale antagonista: la missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM) è sempre più fragile e fratturata.
Il governo somalo, che dovrebbe essere il più forte competitore di Al Shabaab per vincere i cuori e le menti dei somali, non si fa amare dai suoi cittadini per la corruzione che lo pervade.
Cosa si potrebbe cercare di fare?
Le forze militari che combattono Al-Shabaab dovrebbero mantenere, se non incrementare, la loro pressione per creare uno spazio sufficiente allo state – building somalo. Questo includerà lo screditare la violenta interpretazione dell’Islam che motiva la leadership del gruppo estremista e che attira reclute.
Uno dei maggiori sforzi dovrebbe essere condotto dal governo somalo nella direzione di fornire più governance competente e al più presto.